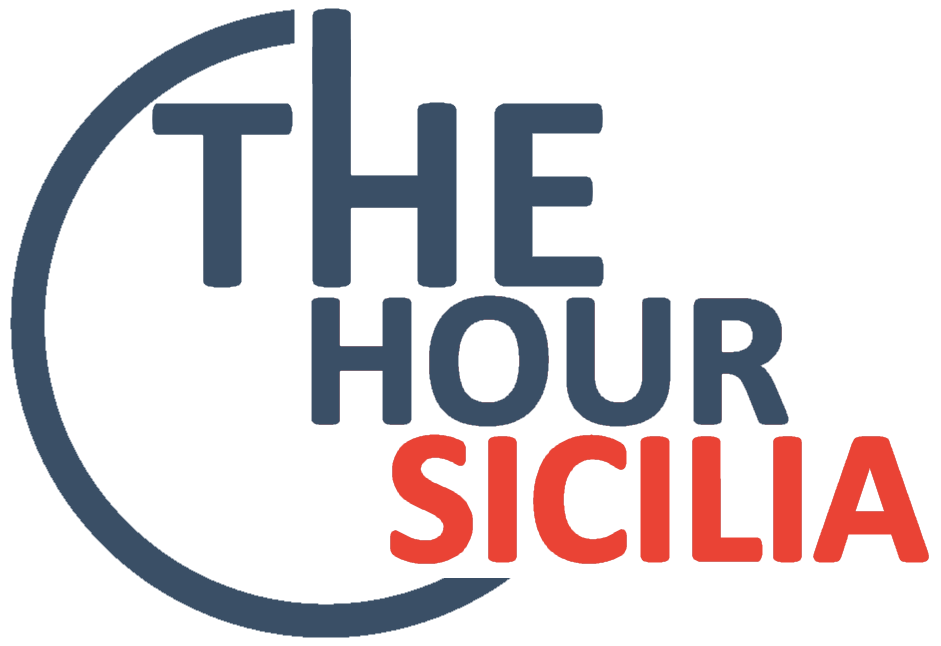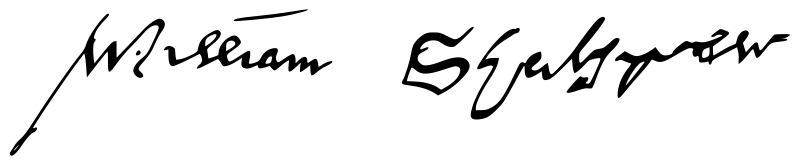- IL GRUPPO DI BILDERBERG E IL TRAMONTO DELL'ECONOMIA ITALIANA - Non sempre concordiamo con le tesi del BLOG La Cruna dell'Ago. Ma gli articoli vanno letti perché sono interessanti e ben documentati (qui l'articolo sull'influenza di Bilderberg in Italia).
- SI VA VERSO LA FINE DEL DOMINIO DELLA FINANZA EBRAICA NEL MONDO?
- Cosa c'è dietro le mosse del nuovo presidente americano Donald Trump su dazi doganali, FED, dollaro americano e rapporti privilegiati con la Russia Putin e i Paesi del BRICS. Articolo illuminante di Cesare Sacchetti nel blog La Cruna dell'Ago (qui potete leggere l'articolo)
- LA MASSONERIA RISCHIA DI SCOMPARIRE, TRAVOLTA DA LOTTE INTERNE?
- Se volete conoscere cosa sta succendo nella massoneria mondiale e nella massoneria italiana vi consigliamo di leggere questo articolo pubblicato dal blog LA CRUNA DELL'AGO a firma di Cesare Sacchetti. Trump e Putin in difesa della cristianità (qui l'articolo).
- ZELENSKY HA VENDUTO ARMI A ISRAELE CHE LE AVREBBE UTILIZZATE A GAZA? - Questa è una delle rivelazioni che trovate nel nuovo articolo che potete leggere nel Blog 'La Cruna dell'Ago' di Cesare Sacchetti. Troverete altre notizie che non è esagerato definire sconvolgenti (qui l'articolo).
- VERSO UNA NUOVA 'STRATEGIA DELLA TENSIONE' EUROPEA? - "Il piano dei servizi segreti francesi e inglesi per destabilizzare l'Europa attraverso una nuova Gladio". Questo il titolo di un interessante e un po' spaventoso articolo che va su 'La Cruna dell'Ago', il blog di Cesare Sacchetti. Un'interpretazione originale su quanto sta avvenendo oggi nel mondo (qui l'articolo da leggere)
- LA MASSONERIA ITALIANA VERSO LO SCISMA? LA DOMANDA CI STA TUTTA DOPO L'INTERVENTO DELLA MAGISTRATURA - Se siete interessati a capire cosa sta succedendo dentro la Massoneria del nostro Paese vi consigliamo di leggere un articolo di Cesare Sacchetti sul blog 'La Cruna dell'Ago'. Un'inchiesta che ripercorre la storia della Massoneria mondiale e svela i retroscena di uno scontro violentissimo tra i 'grembiuli' (qui l'articolo sulla lotte interne alla Massoneria).
- FACCIAMO PIAZZA PULITA DI TUTTE LE INESATTEZZE SCRITTE SUL REGNO DELLE DUE SICILIE - C'è chi non è adeguatamente informato e crede che il Regno delle Due Sicilie sia nato nel 1816, quando il glorioso Regno di Sicilia venne unificato con il Regno di Napoli. Le cose non stanno affatto così. Proviamo ad approfondire questo argomento (qui un articolo).
- CONTINUIAMO CON I PIEMONTESI DAL 1861 AL 1870: ECCO COME AMMAZZAVANO I SICILIANI - A Licata madri e figlie torturate e uccise. Ragazzi frustati e poi infilzati con le baionette. Questo ed altro a Girgenti, Licata, Sciacca, Favara, Calatafimi, Marsala, Bagheria... (qui l'articolo).
- COME I PIEMONTESI, DOPO ESSERSI IMPOSSESSATI DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, TORTURAVANO I CALABRESI - Sono testimonianze incredibili che vengono tenute nascoste per non turbare la falsa storia del Risorgimento nel Sud Italia e in Sicilia ancora oggi raccontata nei libri di storia ufficiali (qui un articolo)
- CON IL DENARO RUBATO AI SICILIANI GARIBALDI PAGA I MERCENARI E I TRADITORI - La vera storia di mille in Sicilia. Una storia di corruzione 'pilotata' dagli inglesi per fare fuori il Regno delle Due Sicilie (qui un articolo).
- QUANTI SICILIANI HANNO SCANNATO I GENERALI PIEMONTESI DAL 1860 AL 1863? - Il Risorgimento in Sicilia è stato un equivoco e un imbroglio. I siciliani hanno reagito ai nuovi invasori. Tante le rivolte popolari, da Palermo ad Agrigento, da Resuttano a Biancavilla, da Trecastagni a San Filippo D'Agira, da Castiglione a Noto, da Mascalucia ad Aci Sant'Antonio, da Paternò a Riposto... (qui un articolo).
- IL RISORGIMENTO IN SICILIA? UN IMBROGLIO. LA VERA STORIA DI GIUSEPPE LA FARINA, STEFANO TURR E NINO BIXIO - Sono tre 'banditi' che ancora oggi vengono celebrati come 'patrioti'. Questi tre signori, in Sicilia, al tempo dell'invasione dei mille, ne hanno combinate di tutti i colori. Ecco le loro storie (qui un articolo).
- GLI UFO? UN INGANNO DELLA MASSONERIA - Non siamo molto d'accordo con questa tesi. Ma l'articolo di Cesare Sacchetti pubblicato nel Blog La Cruna dell'Ago merita di essere letto (qui l'articolo che nega l'esistenza degli UFO).
- I POTERI E I NOMI DEI POTENTI CHE CERCANO DI UCCIDERE TRUMP - Perché stanno cercando in tutti i modi di eliminare il candidato Repubblicano alla guida della Casa Bianca? Un articolo del blog La Cruna dell'Ago svela i retroscena dei due attentati mancati (qui l'articolo di Cesare Sacchetti).
- LA VERITA' SULLA NASCITA DI ISRAELE - Senza Adolf Hitler, il grande persecutore degli Ebrei, lo Stato di Israele non avrebbe visto la luce. Interessante articolo di Cesare Sacchetti nel suo blog La Cruna dell'Ago (qui l'articolo di Cesare Sacchetti). Si può anche non essere d'accordo ma vale la pena di leggerlo.
- LA PAURA DI PASSARE PER RAZZISTI GIUSTIFICA TUTTO? - Possibile che la televisione, in qualche caso, ommetta di dire che eventuali stupratori non sono italiani per paura di passare per razzisti? (qui un articolo).
- ATTENZIONE ALLA TRUFFA DELLO SPECCHIETTO DELLE AUTOMOBILI - Riprendiamo una denuncia dell'Associazione Comitato Civici di Palermo per aiutare i cittadini a difendersi (qui l'articolo).
- SESSUALITA SFRENATA: I SILENZI SULLA PEDOFILIA IN BELGIO - Perché si parla tanto della pedofilia nella Chiesa Cattolica e non si parla quai mai della pedofilia diffusissima in Belgio? E come mai le inchieste penali sulla pedofilia finiscono sempre in bolle di sapone, dal Belgio all'Italia, dalla Germania all'Inghilterra? (qui un articolo).
- CASO SANGIULIANO-BOCCIA OLTRE LE APPARENZE - Se siete interessati ad approfondire una vicenda apparentemente semplice leggere questo articolo (qui).
- I VIRUS CHE NON ESISTONO - Il virus dell'HIV non è mai stato isolato. Il virus Sars-Cov2 non è mai stato isolato. L'ultimo arrivato, il virus delle scimmie,non è mai stato isolato. Ci prendono in giro? (qui l'inchiesta di Cesare Sacchetti)
- LA STORIA DEL DELITTO DI GIACOMO MATTEOTTI
- Cesare Sacchetti su La Cruna dell'Ago ricostruisce i retroscena dell'omicidio di Giacomo Matteotti. Partendo dalla testimonianza dei figlio Matteo Matteotti (qui l'articolo)
- NON SI RIDUCE IL DIVARIO TRA NORD E SUD
- In Italia il divario economico e infrastrutturale tra Nord e Sud non accenna a diminuire. Lo certifica anche la Nona Relazione sulla coesione europea (qui un articolo de il Punto).
- IL BRITANNIA E L'ITALIA A 'SPEZZATINO'
- Cosa avvenne la notte del 2 Giugno del 1992? Inizia la fine dell'Italia che, per volere degli anglosassoni, verrà piano piano svenduta. Una lettura necessaria per capire perché oggi il nostro Paese è alla frutta (qui l'articolo de La Cruna dell'Ago).
- LA GIOVANE FOLLIA AL POTERE A ROMA
- La storia di Eliogabalo, l'imperatore romano strano e bizzarro per antonomasia. Una minibiografia (leggi qui l'articolo di QUORA).
- IL PIANO DEL GOVERNO PER RENDERE STRADE E STAZIONI FERROVIARIE SICURE
- Mille e 400 militari in più per rendere le strade e le stazioni ferroviarie più sicure. Lo ha annunciato il Governo di Giorgia Meloni (come potete leggere qui).
- UN ULTRA 65ENNE SU QUATTRO RINUNCIA A CURARSI PERCHE' NON HA I SOLDI
- In Italia, su quattro cittadini che hanno superato i 65 anni di età, uno rinuncia alle cure per costi elevati, liste di attesa e paura del Covid (qui un articolo di sanità informazione).
- PRIMI A CAPIRE CHE L'EUROPA E' CON LE 'PEZZE AL CULO' SONO GLI EUROPEI - Oltre il 70% dei cittadini europei prevede che il proprio tenore di vita diminuirà nel 2024. È quanto emerge da un'indagine commissionata dal Parlamento europeo. Il 37% degli intervistati ha ammesso di avere difficoltà a pagare le bollette.
- IN FRANCIA MERDA CONTRO LA GLOBALIZZAZIONE - In Francia gli agricoltori protestano contro l'importazione di prodotti agricoli dall'universo mondo. E' una contestazione contro la globalizzazione che piace tanto a chi ha piazzato Emmanuel Macron all'Eliseo. La protesta degli agricoltori francesi consiste nell'imbrattare di merda gli edifici amministrativi. Merda contro la globalizzazione.
- RUSSIA E IRAN SEMPRE PIU' VICINI CONTRO L'OCCIDENTE - Il Ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, e il Ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amir Abdollahian, hanno firmato un accordo per contrastare le sanzioni. Il riferimento dovrebbe essere alle sanzioni occidentali che colpiscono questi due Paesi sempre più in sintonia contro l'Occidente.
- E' L'UNGHERIA O TUTTA LA UE CHE NON VUOLE PIU' DARE SOLDI ALL'UCRAINA? - L'Ungheria non appoggerà la decisione di avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. E si opporrà allo stanziamento di 50 miliardi di euro in favore della stessa Ucraina. Non si capisce se sia la volontà dell'Ungheria o se sia un gioco delle parti organizzato dalla Ue per non dare più soldi all'Ucraina.
- PALERMO AGLI ULTIMI POSTI PER QUALITA' DELLA VITA - Palermo si trova agli ultimi posti in Italia per qualità della vita. Se è così perché tanti registi scelgono Palermo per girare i loro film? La città non è tenuta bene, certo. Forse Palermo, da oltre un decennio, paga l'immondizia nelle strade e le stesse strade e marciapiedi che cadono a pezzi.
- IL DILEMMA - Corte dei Conti per la Sicilia o Corte dei Conti per l'Italia? Non si tratta di una domanda retorica ma della chiave di volta per capire perché rischiamo di finire come l'Isola Ferdinandea (che dalle parti di Sciacca si chiama Isola Giulia) che affondò.
- EGREGIO IGNAZIO CORRAO, LA UE E' FINITA - Ignazio Corrao, eurodeputato eletto nel collegio Sicilia-Sardegna, pensa ancora che la procedura d'infrazione appioppata dalla Ue all'Italia in merito ai mancati bandi per le spiagge sia un fatto grave. La procedura d'infrazione 'europeista' oggi è solo carta straccia perché l'Unione europea è in dissolvimento. Ed è meglio che le spiagge italiane restino agli italiani e non finiscano nelle mani straniere, tedesche soprattutto.
- ATTACCO INFORMATICO ALLA PIU' GRANDE BANCA DEL MONDO (CON PAGAMENTO DI RISCATTO) - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), che è considerata la più grande banca del mondo, avrebbe pagato un riscatto dopo aver subito un attacco di hacker. La notizia la leggiamo in un articolo pubblicato da RENOVATIO 21. Si sarebbe trattato di un grande attacco informatico che ha messo in crisi anche i sistemi di posta elettronica.
- LA RUSSIA REGALA GRANO AI PAESI AFRICANI - Una nave russa con 25 mila tonnellate di grano è salpata dal porto di Novorossijsk, sul Mar Nero, diretta in Africa. Il grano verrà regalato ad un Paese africano. La Russia è il più grande produttore al mondo di grano e sta regalando tanto grano ai Paesi africani. Questo contribuisce a non far lievitare il prezzo del grano nei mercati internazionali.
- UN ROBOT SCAMBIA UN UOMO PER UN PEPERONE E LO UCCIDE - Un robot industriale ha scambiato un lavoratore per una scatola di peperoni e l'ha sbattuto sul nastro trasportatore. L'uomo è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate alla testa e al torace. E' successo a Gyeongsang, nella Corea del Sud. Chissà quante ne vedremo tra robot e intelligenza artificiale.
- LA CRISI ECONOMICA DELLA UE IN UN RAFFRONTO CON GLI USA - L'economia dell'Unione europea oggi rappresenta il 65% dell'economia degli Stati Uniti d'America. Dieci anni fa rappresentava il 91% dell'economia statunitense. Lo scrive il Financial Times, notizia rilanciata da un canale Telegram.
- SOGNO DEMOCRATICO AMERICANO: Un sorteggio al posto delle elezioni presidenziali. E' la proposta che arriva da un docente universitario americano. Potrebbe essere un modo per fare rieleggere il presidente uscente, il Democratico Joe Biden. Invece di 'taroccare' le elezioni, come avvenne nel Dicembre del 2020, si 'taroccherebbe' solo il sorteggio con notevole risparmio di soldi ed energie...
- AL VIA LA NUOVA SERIE DEL SERIAL "REINDUSTRIALIZZAZIONE DI TERMI IMERESE CON CASSA INTEGRAZIONE INFINITA" - Continua il serial a puntate della reindustrializzazione di Termini Imerese. A oltre dieci anni dalla chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese si va avanti con Cassa integrazione e bandi che si risolvono sempre in investimenti di denaro pubblico che risultano fallimentari. Il serial è iniziato con il Governo regionale di Raffaele Lombardo e continua fino ad oggi. Un grande successo per la Sicilia che punta su televisione, cinema e teatro...